
Rigore e coerenza da una parte, profonda umanità dall’altra: fu questo il servizio reso alla magistratura da Rosario Livatino, «il giudice ragazzino» ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica, proclamato tale un anno fa, il 9 maggio 2021, dopo che le autorità vaticane hanno giudicato quel delitto commesso anche «in odio alla fede» praticata dallo stesso Livatino. La data di beatificazione non fu casuale: nel 1993, proprio il 9 maggio, Giovanni Paolo Secondo, nella Valle dei Templi, rivolse il suo invito perentorio ai mafiosi: “Convertitevi! una volta verrà il giudizio di Dio!».
Nell’imminenza del primo anniversario della beatificazione del magistrato, il segretario di stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha lodato «l’esempio luminoso» di Livatino. Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni: tra queste una in Toscana, in un luogo simbolo - la tenuta di Suvignano, nel senese, sequestrata alla mafia - dove proprio il 9 maggio si svolgerà un convegno sul tema «Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili», frase pronunciata dallo stesso Livatino che si interrogava su cosa accadrà «quando moriremo».
Quando Livatino, che aveva 38 anni, fu ucciso dalla mafia quasi non lo conosceva nessuno, ad eccezione dei suoi aguzzini: lavorava al Tribunale di Agrigento e trascorreva le sue giornate tra polverosi fascicoli, occupandosi prevalentemente di sequestri e confische di beni sottratti ai mafiosi. Questo valse la sua condanna a morte decretata dagli uomini della Stidda, organizzazione mafiosa agrigentina, quattro dei quali poi condannati all’ergastolo. Lo attesero lungo la statale che ogni mattina percorreva in auto dalla sua casa di Canicattì - che quattro mesi fa la Regione Siciliana ha deciso di acquisire al proprio patrimonio - al tribunale di Agrigento. Aveva rifiutato la scorta: implorò i «picciotti» assassini di fargli salva la vita, per tutta risposta ricevette in viso il colpo di grazia.
Per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro - i mafiosi lo definivano, con spregio, «santocchio» proprio per la sua frequentazione della Chiesa - fu avviata la causa per elevarlo agli altari. Nel decreto sul martirio è scritto che Livatino era ritenuto inavvicinabile dei suoi persecutori, “irriducibile a tentativi di corruzione proprio a motivo del suo essere cattolico praticante. Dalle testimonianze, anche del mandante dell’omicidio, e dai documenti processuali, emerge che l’avversione nei suoi confronti era inequivocabilmente riconducibile all’odium fidei (odio della fede)», al punto che, inizialmente, i mandanti avevano pianificato l’agguato «dinanzi alla chiesa in cui quotidianamente il magistrato faceva la visita al Santissimo Sacramento».
Di Livatino resta anche una impronta di forte attualità di impegno civile riguardo, ad esempio, al rapporto tra magistrati e politica. Parlando nel 1984 ad un convegno sul ruolo del giudice, disse: «Sarebbe sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall’ordine giudiziario».
Dopo l’omicidio di Livatino, gli investigatori impiegarono mesi per decodificare l’acronimo «S.T.D.», riportato su appunti, documenti e quaderni del magistrato e inizialmente scambiato per un codice segreto. Alla fine si scoprì che si trattava di un costante affidamento che Livatino faceva a Dio: le tre lettere stavano per «Sub Tutela Dei» (sotto la protezione del Signore”), principio ispiratore della sua vita e segno di una spiritualità profonda.




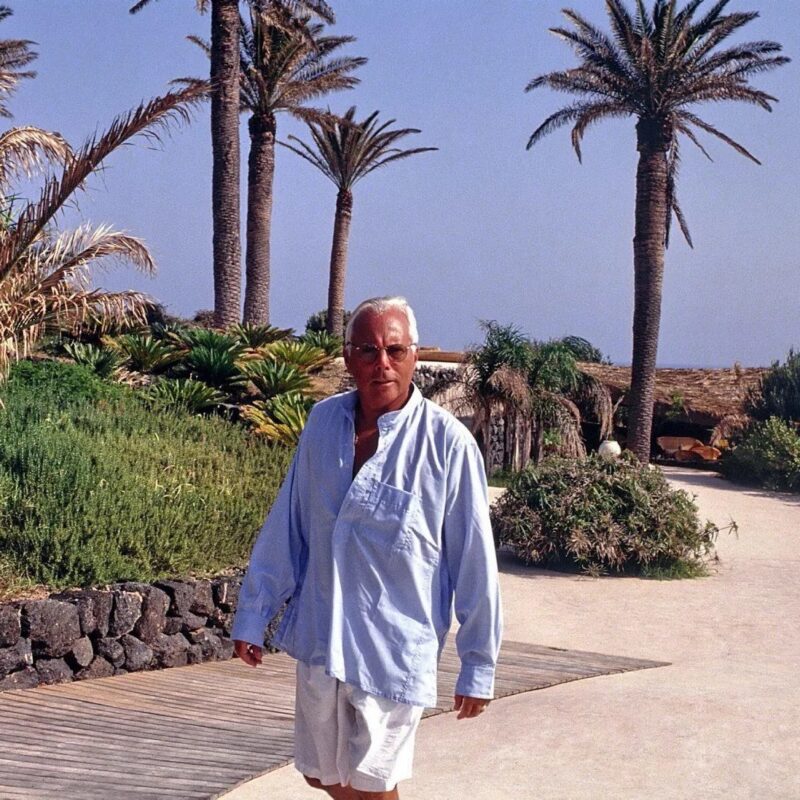






Caricamento commenti
Commenta la notizia